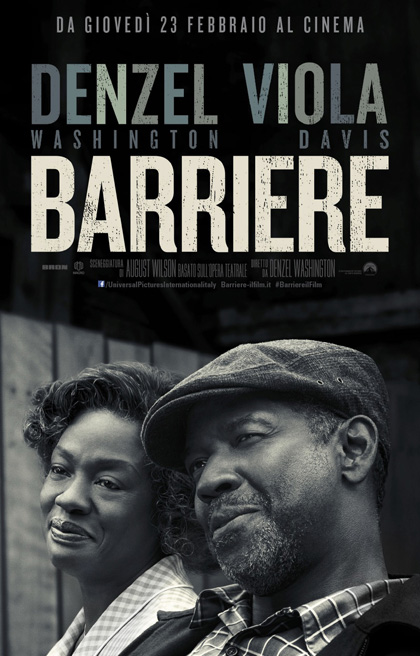Con Vorrei star fermo mentre il mondo va, pubblicato da Mondadori nel
2010, Simone Marcuzzi, classe 1981, analizzava il passaggio di un diciottenne
all’età adulta. Questo Dove si va da qui
pare essere il suo naturale sviluppo, in cui i protagonisti più anziani e già
realizzati professionalmente sono costretti dalla vita a prendere delle
decisioni senza possibilità di fuga.
Marcuzzi è bravissimo a
rappresentare il contemporaneo quotidiano, fatto di viaggi in automobile, di
colazioni consumate fugacemente, di cene scaldate, di telefonate, di pranzi in
famiglia. L’architettura della coppia è costruita con distacco dallo scrittore
friulano; un lucido distacco che pone Gabriele e Nadia esattamente sullo stesso
piano, osservati esattamente dalla stessa distanza. Sono persone adulte e mature
quelle che si muovono in Dove si va da
qui, ma anche vulnerabili e soprattutto umane, capaci di amare, ma incapaci
di dimostrarlo in una provincia italiana sconvolta dalla crisi economica che
spazza via la complicità della coppia, la sicurezza e soprattutto trasforma
quella convivenza basata su una solida routine in una lotta alla sopravvivenza.
Una battaglia per rimanere a galla quando il cambiamento è necessario, ma tutto
è immobile; quando l’amore c’è, ma non è sufficiente.