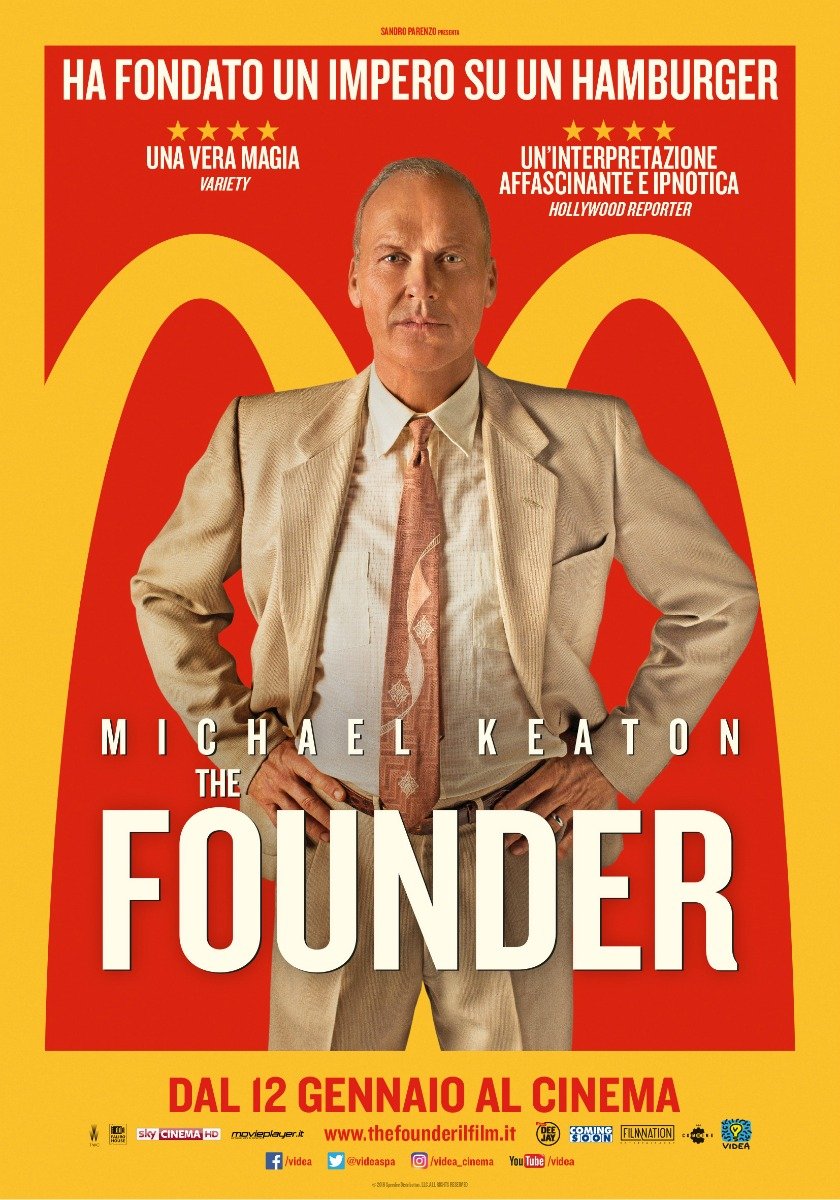Chiron, giovane afroamericano,
vive nella parte più degradata di Miami fra droga e criminalità. Attraverso tre
età della vita, infanzia, adolescenza e età adulta, Chiron cerca di trovare il
proprio posto nel mondo, scoprendo la sua sessualità e soprattutto l’amore per
il suo miglior amico.
Moonlight,
secondo lungometraggio di Barry Jenkins, ribadisce l’esistenza di un cinema
espressamente black, un movimento
afroamericano, il cui maggior esponente è sicuramente Spike Lee, capace di suscitare
interesse in critica e pubblico tanto da garantirsi una diffusione mainstream.
Moonlight
è un condensato dei temi che condizionano e caratterizzano la faccia brutta delle
metropoli americane. Il degrado delle periferie, lo spaccio di droga, la
prostituzione, il bullismo; Barry Jenkins affronta ognuna di queste tematiche
senza però sviscerarle e approfondirle. Tutto rimane solo sfiorato, accennato,
non detto: il regista preferisce la ricerca di un intimismo e di una forma
poetica attraverso una fotografia elaborata, una triste colonna sonora e
soprattutto la recitazione degli attori, tra le poche note della pellicola. I
tre attori che interpretano Chiron nelle diverse età, Mahershala Ali nella
parte dello spacciatore dal cuore d’oro Juan, e Naomie Harris nelle vesti della
madre tossicodipendente di Chiron risultano perfetti, grazie alla loro
struggente interpretazione, a coprire il difetto principale di Moonlight: quella voglia ossessiva del
regista di allontanarsi da qualsiasi etichetta e categoria che si possa
appioppare al suo film. Moonlight è
sostanzialmente un dramma di formazione a tinte gangsta che non si accontenta di essere ciò che è, evidenziando un’incompatibilità
di fondo fra quel lirismo ricercato e quei temi di crudo realismo che il film
vorrebbe trattare.
L’ambizione di Moonlight, quella di coniugare l’afroamericano
all’LGBT fallisce nei silenzi e nei virtuosistici movimenti di camera ricercati
dal regista, che trasforma la sua pellicola in un sofisticato quanto inutile
esercizio di stile, che riduce (in termini di numero) il suo pubblico a una
schiera di cinefili comodamente seduti in poltrona e lontani anni luce dalle
periferie mostrate sullo schermo.