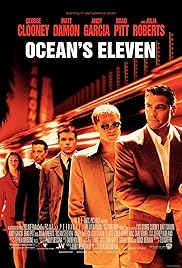Dopo la
prima guerra mondiale, Tom Sherbourne (Michael Fassbender), turbato dagli
orrori del conflitto, chiede di essere nominato guardiano di un faro di un’isoletta
tra l’oceano indiano e l’oceano antartico. Un giorno, assieme alla moglie
Isabel (Alicia Vikander), trova una barca a remi naufragata con a bordo il
cadavere di un uomo e una bimba che piange. Tom, scosso dall’accaduto e ligio
al suo dovere di guardiano vorrebbe denunciare l’accaduto, ma Isabel, con già due
aborti spontanei alle spalle, riesce a convincere il marito a tenere la bimba e
crescerla come fosse loro figlia. Non molto tempo dopo però, la coppia fa la
conoscenza di Hannah Roennfeldt (Rachel Weisz) madre naturale della piccola,
risoluta a riavere indietro la bambina che credeva morta.
La luce sugli oceani, scritto e diretto da Derek Cianfrance, è un
melodramma in piena regola, un condensato di situazioni e sentimenti che
ciclicamente Hollywood si impegna a realizzare. Purtroppo La luce sugli oceani è un film mediocre. Purtroppo perché le
musiche di Alexandre Desplat sono perfette e sposano alla perfezione i
movimenti di camera di Cianfrance, la fotografia di Adam Arkapaw e i volti di
Fassbender, della Vikander e della Weisz. Purtroppo perché è un film tecnicamente
corretto, sontuoso per la ricerca e ricostruzione degli ambienti e dei costumi,
ma troppo impegnato nella ricerca ossessiva della lacrima, dell’emozione e di
un sentimento che alla fine risulta più stucchevole che spontaneo. Il dramma di
una coppia che si vede portar via la figlia dalla madre naturale vorrebbe
essere il suggerimento allo spettatore per una analisi coscienziosa su cosa
voglia dire veramente prendersi cura di una persona. È uno spunto di
riflessione che si può cogliere nel personaggio di Fassbender, uomo
responsabile in preda ai sensi di colpa, la cui crisi interiore però è sepolta
da Cianfrance da una coltre fatta di lettere d’amore, di lacrime, di lunghi
primi piani; la piccola Lucy, sorta di MacGuffin
della vicenda, diventa un oggetto, mentre l’essere genitore sembra più un possedere
che un accudire.
È genitore
colui che crea o colui che cresce il bambino? Ecco, La luce sugli oceani ha l’ambizione di voler suggerire un simile
quesito, a cui però non trova risposta e nemmeno si impegna per cercarne una.
Quello che fa, per i suoi eterni 133 minuti di durata, è voler far piangere il
pubblico attraverso le interpretazioni dei suoi tre attori principali, colonne
portanti di un film claudicante in più punti.